NARRIAMO STORIE, NON IDEOLOGIE!
di Francesca Corbella
La Disney qualche mese fa ha messo il bollino rosso ad alcuni dei suoi classici come Dumbo, Peter Pan e Gli Aristogatti, vietandoli ai minori di 7 anni: i tre film “trasmettono stereotipi di genere e messaggi dannosi e razzisti e restano visibili solo da un pubblico adulto”. Sì! avete capito bene: i tre corvetti di Dumbo, gli unici veramente soccorrevoli del piccolo disperato, trasmetterebbero un messaggio diseducativo. Mah! A ciascuno di giudicare se l’educazione sta o no nel politically correct dei tempi moderni, dove l’estremizzazione ideologica rischia di inficiare anche buoni e sani principi antidiscriminatori.

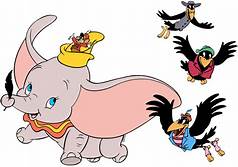
Ma veniamo alle favole, quelle cioè che narrano storie di animali o di esseri soprannaturali come maghi e streghe, che troviamo nella tradizione popolare delle Alpi, degli Appennini e di tutte le zone rurali d’Italia. E alle fiabe, quelle dove i protagonisti sono essenzialmente umani, come la più diffusa a livello planetario, Cenerentola, e gli immortali protagonisti di Andersen e dei F.lli Grimm, oltre a moltissime altre.

In fiabe e favole l’errore più grande è di considerarne gli elementi, elementi reali mentre essi, tutti – sia animali sia umani – hanno esclusivamente un valore simbolico. il lupo non è un lupo vero e non intende affatto trasmettere ai bambini il senso della ferocia del predatore, da temere e desiderare di ucciderlo. Cenerentola non è la donna immiserita che si riscatta solo ed esclusivamente tramite l’uomo ricco e potente. E’ felice anche nelle sue mansioni umili! E’ amata proprio per questo dai suoi confidenti animali.
Questi giudizi sono quelli formulati dalla Disney da dare in pasto al popolino basso con argomentazioni demagogiche. Noi dobbiamo invece approfondire l’indagine in modo sottile, capire perché questo genere di narrativa è e rimarrà sempre la preferita dai bambini, capire qual è il significato profondo e l’insegnamento delle azioni e delle figure narrate, tenendo conto dell’origine, dei contenuti, della forma della comunicazione.
Le fiabe non esistono nello spazio e nel tempo, ritroviamo gli stessi concetti in tutto il globo, per quanto le singole storie siano radicate localmente e si sviluppano intorno a tradizioni territoriali specifiche.
Credenze e immagini sono di lunga durata, non si conosce la data di nascita! Pensate a quanto antiche sono le leggende del greco Esopo (VI sec. aC) e poi a Fedro vissuto nella Roma di Tiberio de I secolo dc, La Fontaine nel 1600 e pensate anche alla trazione favolistica del nostro Ottocento (Pinocchio) e Novecento con Calvino, Trilussa, Pancrazi, Gadda.
Sono tramandate oralmente e poi scritte dai tempi antichi e sono un bagaglio di vitali acquisizioni dello spirito umano, della civiltà, di cui costituiscono un patrimonio inalienabile. Le fiabe sono la garanzia della continuità culturale intergenerazionale perché nascono dalla necessità di raccontare con efficacia, mediante simboli, profonde verità sociali o morali: la pigrizia viene punita, i furbi prevalgono ma poi vanno a gambe all’aria perché trionfano i saggi e gli umili intelligenti. Il più piccolo viene dileggiato come inferiore ma poi riscatta i fratelli che erano più prepotenti ma stolti. E’ narrata sempre la volontà di condannare i vizi, l’intento di riuscire a sopravvivere grazie alla virtù. I vizi spingono ad azioni abbiette, le virtù ad azioni sublimi. In Cenerentola ci sono i simboli della donna buona e servizievole ma anche quelli dell’altezzosa e arrogante (la matrigna). Cenerentola, sfruttata e umiliata, ha in sé la grazia e la gentilezza, mentre le sorellastre potenti e capricciose sono goffe e sgradevoli. Non si deve pensare che il Principe rappresenti il riscatto della donna, in quanto bello e ricco. Si deve rivestire il suo ruolo di simbolismo: l’uomo come fondamentale complemento della donna. Il bacio è la congiunzione, l’unione che fa la forza e il riscatto, sia dell’uno che dell’altra. Entra in gioco una fisicità lieve, aggraziata, che nulla ha a che fare con la grezza manifestazione di altra corporeità che entra in gioco volgarmente nella comunicazione di oggi, per esempio cinematrografica e televisiva, anche destinata ai più piccoli.
L’ossessione femminista individua nel principe il maschio che impone il matrimonio a sua scelta: è proprio il contrario! nella favola il principe è l’emblema della purezza maschile, che supera ostacoli con coraggio e volontà per raggiungere, a dispetto di ogni convenzione sociale dell’epoca (lei era una serva) il proprio scopo nobile: l’amore. Anche questo non è da intendersi scioccamente come l’amore romantico: l’amore romantico è una iettatura per sciocchi: nelle fiabe tradizionali l’unione amorosa è quanto di più giusto esista da dare come insegnamento ai bambini, non è idealizzato ma profondo. E’ l’unione dei complementari, è l’interdipendenza fruttuosa di uomo e donna. Il vissero felici e contenti significa solo questo: il credere fermamente, il lottare, l’amare con tutti sé stessi, oltre i muri delle convenzioni e delle difficoltà che la vita pone, senza capriccio o volubilità, ma con saggezza e determinazione, questo è il punto ideale a cui tendere, che la fiaba enfatizza.
La fiaba ha un’importanza pedagogica enorme: ricorrenti sono le figure familiari, mamma (saggia, amorevole), figli (incauti e inesperti), nonna (malata e vulnerabile), cacciatore amico che sostituisce la figura maschile/paterna perché forte e giusto; e c’è la casa, emblema della solidità famigliare o del nido materno dal quale il bambino piccolo si emancipa (I tre porcellini); si ritrova anche sempre l’ammonimento materno, il buon consiglio che accompagna il viaggio e conforta; sempre presente è la strada perigliosa (Cappuccetto Rosso) simbolo dell’autonomia verso la vita adulta; e ancora ritroviamo il leit-motive del pericolo (lupo) dal quale la mamma accorta aveva messo in guardia il figlio.
E ci sono gli elementi comuni della vita: l’ingenuità, la furbizia, la fiducia tradita, la menzogna e l’inganno (il lupo invita Cappuccetto a fare una gara e poi la spinge verso la strada più lunga per poter giungere per primo e mangiarsi la nonna!).
Alla fine, sempre e comunque, assistiamo al riscatto e quindi c’è un processo di fede, attraverso il quale si arriva alla crescita.
L’attenzione assoluta che prestano i bambini di due/tre anni e anche meno, per tutta la durata della lettura, dimostra che i pedagogisti non si sbagliano. I bambini cercano il significato del vivere. Qualcos che lo ancora alla realtà come solide radici che rimarranno nel tempo per dare senso anche alle bufere della vita. I bambini chiedono di ripetere la stessa storia per decine di volte: è perché essi elaborano i concetti e ne fanno apprendimenti. La fiaba non è mai intrattenimento è sempre apprendimento.
Scegliete fiabe di qualità, con immagini non troppo dettagliate, non propendo per illustrazioni che tolgano la fantasia ai bambini, meglio immagini abbozzate, piccole, semplici. Non ricorrete alle fiabe sul video!!! Meglio ancora nessuna immagine. La voce della mamma è fondamentale!!! Non utilizzate dischi o registrazioni con voci, magari recitate perfettamente ma fredde e anonime. La voce deve essere affettiva, amorevole, deve imprimersi per sempre come il momento d’oro della nostra vista, la voce delle nonna che non c’è più, della mamma quando ci cullava al seno…
In ultimo: il valore del sogno: nelle varie fasi di crescita il bambino ha bisogno di spazio e tempo per sognare: sognare di essere, sognare di diventare, sognare di fare, sognare di avere caratteristiche sue proprie, cammini da percorrere, avventure da compiere, grandezza umana da costruire.
Un bambino può sognare di avere un cane, questo è la rappresentazione del desiderio di giocondità, di affettività, di condivisione, ma anche di assunzione di responsabilità e di scelta importante. Allora legge libri con storie di cani e sogna avventure con cani in Alaska, nella giungla tropicale, in luoghi che presto diventano leggendari, pensate a famosi cani della letteratura, da Salgari a Jack London e tanti altri. Questi animali sono parti dell’anima umana, che vuole realizzarsi espandendosi attraverso i protagonisti fantasiosi di queste storie: pensate al cavallo Furia, al cavallo di Zorro o al cavallo Bucefalo.
I ragazzi hanno bisogno di rapportarsi agli eroi, che non sono persone inesistenti e irraggiungibili, sono semplicemente dei propulsori di sogni, dei “padri” nel senso educativo del termine, degli apritori di piste verso il mondo, coloro a cui riferirsi. Pensate a 007, pensate al Corsaro Nero, a Marco Polo, a Sandokan e Tremal Nike, ma anche a Pippi Calzelunghe, al Piccolo Principe, Piccole Donne, al freddo e crudele capitano di Moby Dick, avventurieri del mare come l’Olandese volante, scopritori del Continente nero, archeologi dell’Antico Egitto, miti della Storia, e quanti altri. A 14 anni si possono leggere migliaia di libri e trovarvi modelli che offrono un bagaglio inestimabile di spunti per la riflessione e la creatività negli anni a venire, allargano la capacità di ascolto empatico verso chi incontriamo, creano occasioni di dialogo e sono un punto di confronto con quanto sperimentiamo.
La Disney quindi sta sbagliando tutto! …Ma il fatturato di sicuro crescerà!
