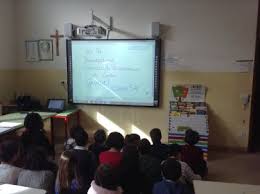BAMBINI IN FORMATO DIGITALE
La crescente pervasività della tecnologia, emersa con l’emergenza covid come reale problematica trasversale alle famiglie e alla scuola, ha portato in evidenza il ruolo che ricopre il digitale nella prima infanzia. Il dibattito non è nuovo infatti molti pedagogisti ed esperti di età evolutiva hanno ampiamente denunciato da tempo gli effetti dei dispositivi digitali e del loro utilizzo sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini. Tablet, smartphone, computer e soprattutto il web entrano nella vita dei bambini da età sempre più precoci, addirittura da lattanti. Ovunque si vedono le pubblicità dei computer per i bebè e dei relative app di giochi, che diventano letteralmente i “padroni” per una media di utilizzo che secondo dati Commissione Europea del 2017 va dalle 2,6 ore/giorno della prima infanzia alle 6 ore degli adolescenti. Si vede anche come ciò porti a situazioni di malessere fino ad arrivare allo sviluppo di vere e proprie dipendenze.

Il terrificante recente fatto di cronaca di Palermo, dove una bimba di soli 10 anni è morta soffocata durante una sfida estrema sulla piattaforma TikTok, ha spinto il dibattito sul fronte della necessità di maggiore regolamentazione, proibizioni, vincoli da porre alle piattaforme.
Non è questo però il punto.
Occorre porsi una domanda: è internet che conduce alla perdizione i giovani e giovanissimi o piuttosto è il malesssare alimentato dal nostro sistema parossistico a portare i ragazzi a trovare uno sbocco e un riempitivo esistenziale nel web?
Propendo per la seconda ipotesi.
I dispositivi sono diventati estensione dell’io fisico e i social media strumenti di amplificazione identaria, sia individuale che di gruppo.

Proprio qui c’è qualcosa che non va: perchè i giovani hanno bisogno di amplificazione? Chi cerca un mezzo aumentativo è perchè in qualche modo si sente diminuito e stemperato nella massa. E’ nella natura delle tappe evolutive il bisogno di identità, una molla molto forte per la crescita, fin dalla tenera età. Il bambino ricerca il senso di sè attraverso l’autoaffermazione (la fase del no a 3 anni e la ribellione adolescenziale a 13). Tutto ciò è fisiologico: il giovane sfida il mondo adulto attraverso il misurarsi con il padre e la ricerca di altri modelli fuori dalla famiglia, e il mondo naturale attraverso esperienze dirette, prove, avventure, il traguardo sportivo. Questi sono i naturali intermediari tra l’infanzia e l’adultità, che concorrono alla formazione della persona e del suo pensiero originale.
Perchè allora il bisogno di amplificazione? I social, i videogiochi, la rete in genere offrono all’individuo una possibilità di emersione senza la fatica dell’affermazione di sè, senza richiesta di meriti e di abilità comunicativo-relazionali o prestazionali (se non quelle richieste dalla tecnologia). Aboliscono l’esperienza dell’interazione sociale, barattadola con visibilità e accettabilità solo fittizie: “se ricevo dei like sono riconosciuto e amato”. Ma di reale c’è invece l’invisibilità, soggetti spersi nell’anonimato del mare magnum della rete spinti a trovare misure compensative. I giovani emulano e portano a esempio i successi dei coetanei più performanti: videomaker, influencer, acrobati e funamboli vari, spesso del tutto mediocri, che collezionano milioni di like, hanno immagine costruita a tavolino e denaro, molto denaro.
I genitori sono in difficoltà nel gestire i tempi di utilizzo dei device da parte dei figli, non dispongono di strategie per limitarli, non hanno tempo e non hanno ragionevolezza sulle conseguenze, allargano le braccia, dicono “sono i tempi”, “non possiamo estraniarlo dal mondo, lo fanno tutti”; in molti casi utilizzano loro stessi i device come babysitter elettroniche. Spesso i genitori si qualificano pubblicamente in una posizione di rigore al riguardo, ma non è vero, sono debolissimi e non stabiliscono alcun patto educativo con il figlio!
La scuola è fortemente correa, da un lato colpevolizza le famiglie e le lascia sole, dall’altro spinge sull’acceleratore a manetta per digitalizzare la scuola e gli alunni. Così facendo molte funzioni vengono demandate alla tecnologia e diventano di minor peso economico e gestionale per le strutture e il Ministero dell’Istruzione; i ragazzi vengono spinti al ricorso permanente all’informatica (ricerche su Wikipedia, registro elettronico, lim, schede su piattaforme, tecniche di disegno e tutorial pratici da seguire online, riunioni e lezioni via zoom, la politica globalista plaude e finanzia, perchè così facendo ne diventano gli utenti remissivi e assuefatti.
Tramite i social vengono filtrate le informazioni, gli “amici” sono in realtà frutto di algoritmi, i messaggi targettizzati e indirizzati, per non dire censurati. Se ne è avuta evidenza nella campagna elettorale americana. Di questo meccanismo di controllo e di sudditanza ad opera dei colossi della tecnologia nei confronti dei cittadini, le istituzioni e la scuola sono i primi propulsori. Invece proprio i professionisti dell’educazione dovrebbero essere centrali per agire sui fattori di rischio legati all’utilizzo dei dispositivi e all’abuso che se ne fa in giovane età.
Manca inoltre un piano organico di formazione dei docenti, che deve essere obbligatoria e indirizzata verso un uso più critico e consapevole sia dei mezzi sia dei contenuti e della comunicazione mediata.
Perchè è pericoloso per i bambini usare i device?
In comparazione con i pochi vantaggi (migliorare le capacità visuo-spaziali, plasmare la mente al multitasking, aumentare le abilità strategiche e competitive, migliorare l’apprendimento in soggetti con handicap o DSA), l’elenco degli svantaggi è lunghissimo.
Le neuroscienze stanno studiando gli effetti dei nuovi strumenti digitali sullo sviluppo del cervello. Sappiamo che esso, grazie alla sua plasticità è in grado di adattarsi all’ambiente con cui interagisce. Diverse ricerche mostrano come la sintonizzazione con la realtà virtuale rischi di rendere i giovani sempre meno adattati alla realtà offline, con ovvie conseguenze deleterie. L’American Academy of Pediatrics nel 2016 ha pubblicato le Linee Guida per l’esposizione dei bambini piccoli ai device. Raccomanda ai genitori di evitare l’uso degli schermi per bambini inferiori ai 2 anni (2 anni!!!), a tenere le camere dei bambini libere da onde elettromagnetiche e a non ricorrere a questi mezzi come strumenti di regolazione emotiva o intrattenimento (tablet montati sul retro degli schienali dei sedili davanti delle auto).
I primi anni di vita sono un periodo di intenso lavoro per il cervello, l’uso dei device prima dei 7 anni sottrae tempo ed energie utili alla costruzione di nuove esperienze del mondo che risultano fondamentali per favorire uno sviluppo armonico. I media comportano un’inattività sul piano motorio e uno sviluppo sensoriale limitato a vista e udito; fuorviano le reali interazioni sociali dando una parvenza di socialità; lo sviluppo linguistico è a rischio perchè i media offrono un linguaggio ricettivo (ascolto passivo) e non consentono il linguaggio produttivo (parlare con gli altri). La mano, strumento di conoscenza fondamentale nei primi anni, è relegata alla digitopressione dei tasti, e non alla funzione senso-motoria cui invece è naturalmente destinata. La luce del display, imitando l’effetto della luce solare, disturba la relazione sonno-veglia e danneggia la qualità del sonno. L’uso della realtà aumentata amplifica la percezione, mediante un flusso di informazioni che i sensi non sarebbero in grado di percepire e il cervello di organizzare, quindi a livello neuronale c’è un gap. Per non parlare della precocizzazione concettuale, data la disponibilità di informazioni non filtrate per età dei fruitori, come avviene invece nelle tappe evolutive naturali.
La scuola, in base alla L170 del 2010, garantisce agli studenti con disturbi specifi i mezzi di apprendimento alternativi come le tecnologie informatiche. Sicuramente questi mezzi sono utili per molte situazioni di deficit non altrimenti recuperabili, però se la funzione deficitaria può essere potenziata, la tecnologia usata come compensazione può per contro bloccare questo potenziamento e rendere superflua l’abilitazione delle capacità: un alunno può essere demotivato all’apprendimento della matematica dall’uso della calcolatrice, la sostituzione della videoscrittura a quella manuale può impedire il miglioramento, l’uso del registratore come compensazione della difficoltà a seguire le lezioni può inibire l’uso della funzione attentiva.
Le ricerche sul processo di alfabetizzazione inoltre non stabiliscono affatto la maggiore efficacia della videoscrittura sulla scrittura manuale, nè della videolettura sulla lettura tradizionale. Infatti entrambe le formule tradizionali attivano il sistema motorio attraverso l’esecuzione di azioni e gesti significativi (tracciare le lettere con la matita sulla carta, sfogliare le pagine di un libro), motivati ad uno scopo ed essenziali per la formazione dei concetti, anche astratti. I processi cognitivi infatti vengono ancorati a pattern senso-motori che aiutano la comprensione e la memorizzazione, cosa che il digitale non consente (ogni lettera corrisponde alla pressione di un tasto sempre identica).
Molte tecnologie di cui dispongono i bambini richiedono un’accelerazione dei tempi di risposta lasciando sempre meno spazio alla riflessione. Nei videogiochi è costante l’elemento della competizione, vince chi arriva primo, in una gara a tempo permanente che impedisce la metacognizione. L’immaginazione inoltre è incanalata in schemi grafici e strategie di gioco che non permettono lo sviluppo della creatività individuale.
La fascinazione ai device è motivata dal fatto che questi strumenti creano piacere, ogni volta che ci si collega a una app e che si ricevono messaggi, notifiche o si naviga in rete, si attiva un sistema di stimoli che rilasciano dopamina, un neurotrasmettitore rilasciato durante i meccanismi di ricompensa e affettività, quindi il fruitore del mezzo digitale tenderà a correlare quelle sensazioni con l’uso dello strumento. Il meccanismo consolatorio è simile a quello che si innesca in chi assume sostanze stupefacenti.
Le nuove tecnologie abituano a una comunicazione più intensa ma a distanza, senza limiti di spazio e tempo, tutta in contemporanea e in condizioni di potenziale isolamento. Quali forme di empatia si sviluppano senza presenza fisica – la pelle – degli interlocutori? Quale abilità di negoziazione, interazione comportamentale, gestione del controllo emotivo, contenimento dell’ansia, coraggio del confronto, maturazione del senso dell’adeguatezza e autostima?
Per finire, dal punto di vista didattico, la lim a scuola vede l’anteporsi della tecnologia al ruolo dell’insegnante, che fisicamente viene spostato di lato nella classe per lasciare in posizione centrale (e quindi psicologicamente dominante) il mezzo tecnologico. Il “prof” non è più il detentore del sapere e il regolatore del comportamento in classe, non è più la figura autorevole cui rapportarsi, colui che con la sua abilità mantiene l’attenzione e la disciplina, un facilitatore che si chiama computer ha preso il suo posto, tarato per attrarre l’attenzione con colpi di scena, indurre l’immobilità con stimolazioni visivo-uditive, ottenere il silenzio in classe come al cinema. Il ruolo di facilitatore della didattica funge agli allievi ma anche e soprattutto direi al docente, che vi ricorre volentieri prediligendo i contenuti web al proprio apporto, che invece dovrebbe essere molto maggiore in quanto dovrebbe contemplare il sapere ma anche di saper fare e saper essere, in una parola: qualcosa di umano.